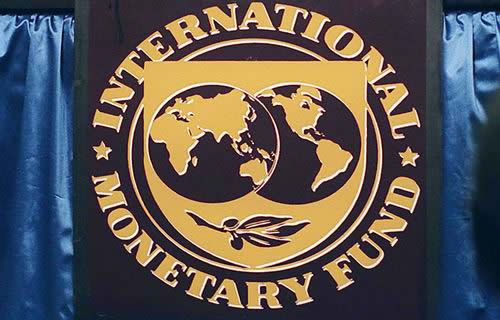Nel ventennio tra le due guerre mondiali fu netto il processo involutivo verificatosi negli scambi internazionali. Ciascun Paese di fronte alla grande depressione del 1929 cercò di salvaguardare l’economia interna mediante misure restrittive (contingentamenti alle importazioni, bilateralismo negli scambi) o mediante misure aggressive di politica commerciale (valuta dumping, premi alle esportazioni). Al tempo stesso, i timori di un possibile conflitto armato determinarono uno spostamento di fondi verso gli Stati Uniti d’America per motivi precauzionali.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale non fece altro che aggravare questa situazione di isterilimento degli scambi con la rottura delle relazioni commerciali tra i due blocchi belligeranti.
Con l’intento di porre fine a questa grave situazione economica, prima ancora della fine della fine del secondo conflitto mondiale si tenne a Bretton Woods dal 1° al 22 luglio 1944 l’omonima conferenza con il compito di generare un sistema di regole e procedure per regolare la politica monetaria internazionale. Le caratteristiche principali degli Accordi di Bretton Woods erano due: la prima era l’obbligo per ogni Paese di adottare una politica monetaria tesa a stabilizzare il tasso di cambio ad un valore fisso rispetto al dollaro, che veniva così eletto a valuta principale, consentendo solo delle lievi oscillazioni delle altre valute; la seconda il compiito di equilibrare gli squilibri causati dai pagamenti internazionali, promuovere la cooperazione monetaria internazionale, favorire l’espansione e l’armonico sviluppo degli scambi, agevolando in tal modo il mantenimento di un elevato livello di occupazione.
Gli accordi istituirono oltre al FMI anche la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (detta anche Banca Mondiale o World Bank) e nel 1947 venne poi firmato il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – Accordo Generale sulle tariffe ed il commercio) che si affiancava all’FMI e alla Banca Mondiale con il compito di liberalizzare il commercio internazionale.
Il Fondo Monetario Internazionale disponeva di un capitale messo a disposizione dei suoi membri attraverso un sistema di quote nazionali. In linea di principio, la quota attribuita a ciascun Paese doveva riflettere la sua importanza nel commercio internazionale con delle revisioni quinquennali.
Secondo le disposizioni originarie, la quota sottoscritta da ciascun Paese doveva essere versata per il 25% in oro e per il 75% in valuta nazionale. Oltre al pagamento della quota ulteriori obblighi a carico dei Paesi membri erano:
-
dichiarazione della parità monetaria (espressa in oro o in dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio del 1944)
-
dell’adozione di un regime di cambi fissi (con limitate oscillazione nell’ambito dell’1% rispetto alla parità)
-
dell’assunzione di impegni concernenti la stabilità dei cambi e consultazione preventiva al fondo sulle decisioni da prendere qualora l’eventuale modifica della parità ecceda il 10% della parità stessa.
Con l’istituzione del FMI si è in parte superata quella situazione di stallo e si è sviluppato il multilateralismo degli scambi. Esiste infatti l’obbligo per i Paesi membri ad effettuare la convertibilità dei saldi di pertinenza estera, la cosiddetta “convertibilità per non residenti“. Ciò significa che un Paese che abbia acquisito crediti verso un determinato Paese per effetto di regolari scambi commerciali possa ottenere i pagamento nella valuta da esso preferita senza essere costretto all’acquisto di merci del Paese debitore per realizzare il proprio avere.